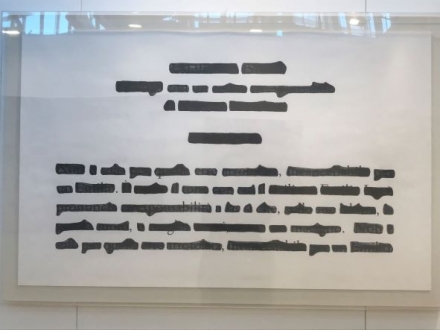Il prigioniero coreano. Kim Ki-Duk realizza un film scarno e ruvido e si confronta con la storia del suo Paese

Nam Chul-woo (Ryoo Seung-bum) è un pescatore nordcoreano che, per un guasto al motore, sconfina nella Corea del Sud. Comincerà per lui un calvario, prima in terra straniera dove verrà accusato di essere una spia e poi tornato in patria quando dovrà dimostrare la sua fedeltà al regime.
Non è la prima volta che Kim Ki-Duk affronta la storia del suo paese.
In Indirizzo sconosciuto (2001) la trama si intrecciava con le conseguenze della presenza americana sul suolo coreano; in The coast guard (2002) il protagonista era una guardia costiera al confine tra i due stati.
Proprio tale divisione è al centro della sua ultima fatica.
Si tratta forse del film più esplicitamente politico del regista che sacrifica tutto affinché il suo messaggio arrivi forte e chiaro.
Come One on one (2014) è girato quasi esclusivamente in interni ed è dominato dai dialoghi. Kim Ki-Duk lascia quasi completamente fuori dalla porta il mondo esterno per concentrarsi sulle stanze in cui Nam Chul-woo affronta la sua detenzione.
Il pescatore del titolo è un uomo che si rifiuta di guardare il mondo circostante, un po’ per necessità (vedere la Corea del Sud lo esporrebbe a pericoli per la sua stessa vita), un po’ come forma di resistenza passiva.
Il suo unico pensiero è quello di tornare a casa dalla sua famiglia. Una spinta tanto forte quanto inconcepibile agli occhi dei poliziotti sudcoreani. Come può infatti quell’uomo desiderare di tornare in quel regime? Sicuramente è vittima di un lavaggio del cervello.
L’unico modo per convincerlo a rimanere, visto che appare evidente che non si tratta di una spia, è quello di ricorrere ad uno stratagemma; abbandonarlo in piena città, tra le vie dello shopping.
Una volta conosciuto il sapore della libertà l’uomo sicuramente non ne potrà fare a meno.
Per Kim Ki-Duk però la nostra libertà è un inganno.
Quando finalmente Nam apre gli occhi quello che vede sono solo cose; oggetti, i simboli dell’accumulazione capitalista. Spendere i nostri soldi per soddisfare i bisogni indotti dal sistema consumistico è l’unica libertà di cui gode l’occidente.
Chi non ha le possibilità economiche finisce ai margini della società, come la prostituta che incontra Nam, costretta a vendere il proprio corpo per aiutare la famiglia.
Kim Ki-Duk, attraverso le parole del protagonista, ci interroga direttamente. Com’è possibile che con così tanta abbondanza ci sia chi rimane escluso? Come si giustifica una tale intollerabile giustizia?
Accanto alle cose l’altra ossessione è sempre materiale e riguarda il cibo.
Al di là dello spendere soldi, l’unica altra libertà che sembra esserci rimasta è quella di non patire più la fame di cui è evidentemente vittima il nordcoreano. Ecco che allora Kim Ki-Duk lo fa mangiare continuamente, voracemente, sino all’eccesso. Persino quando tornerà a casa gli verrà offerto del pollo.
Ma la critica del regista si spinge ancora più in là.
Se il denaro è l’unica nostra forma di libertà allora i soldi sono, letteralmente, merda. Kim Ki-Duk ce lo dice esplicitamente in una scena.
Non c’è modo di fuggire a questa doppia condanna.
Da una parte del confine se non hai soldi non sei nessuno, dall’altra domina la corruzione e tutto si può comprare. L’essere umano diventa allora solo una pedina, non è più padrone di sé stesso. Nam viene usato nel gioco della propaganda dalle due Coree e la sua vita viene completamente distrutta, lui viene disumanizzato e subisce così tanta violenza da diventare persino incapace di fare l’amore con la moglie. Un percorso che porterà Nam sino ad una sorta di sacrificio che ricorda la passione di Cristo. Nel nostro mondo non c’è posto per il povero pescatore, tutti giocano con la sua vita. Siamo tutti vittime sacrificali.
Sembra non esserci nessun barlume di speranza ne Il prigioniero coreano.
L’autore del film è talmente concentrato sulla sua denuncia del nostro mondo da sacrificare tutto il resto in nome della chiarezza.
Kim Ki-Duk vuole che non ci siano dubbi su quello che ci tiene a dire. Di conseguenza costruisce un film verbosissimo, scarno tanto quanto gli ambienti in cui viene interrogato il protagonista. Una nuova forma di cinema che nulla concede allo spettatore e che già aveva fatto storcere il naso a molti nel precedente One on one.
Probabilmente Kim Ki-Duk deve ancora superare la crisi, dovuta all’incidente accaduto sul set di Dream (2008) e poi documentata in Arirang (2011).
Certo il suo cinema oggi appare cambiato, alle volte incerto e traballante e, come in questo caso, totalmente al servizio della denuncia.
C’è un senso di incompiuto nel suo ultimo lungometraggio, una povertà (anche di mezzi) esibita quasi con fierezza che esplode in un finale che forse appare persino di troppo, come se Kim Ki-Duk apparisse incapace di dominare la narrazione, incapace di fermarsi quando e dove dovrebbe, come se fosse interiormente bruciato dalla necessità di mostrare tutto senza badare alla forma.
Eppure, nonostante tutto, questa forma ruvida e grezza finisce comunque con l’affascinare e confermare la grandezza del regista sudcoreano anche nei periodi bui, anche nei film apparentemente incompiuti, minori e meno riusciti.
E poi a chiusura di tutto c’è quell’ultima inquadratura in cui c’è tutta la poetica ed il senso del fare cinema del nostro oltre che l’unica possibile fiammella di speranza per il futuro. Ed è una inquadratura talmente intensa che non puoi non ringraziare Kim Ki-Duk per quello che rappresenta la sua opera.